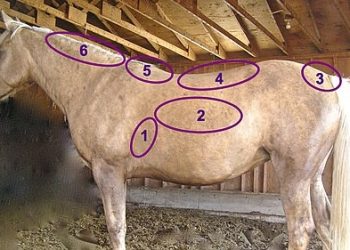Da Vermezzo a Buscate, da Cervia a Narni... tutte le emozioni di un ricco weekend
Da Vermezzo a Buscate, da Cervia a Narni... tutte le emozioni di un ricco weekend
Quando il colonnello britannico Jack Seely partì per il fronte nell’agosto del 1914, decise di portare con sé Warrior, il cavallo nato nella sua tenuta sull’Isola di Wight. Warrior, come già dal nome, era stato allevato con la precisa intenzione di diventare un cavallo da guerra. Seppur questo fosse il suo destino, non era un cavallo spettacolare, ma era un baio resistente, veloce e sorprendentemente equilibrato. E così, un uomo e il suo cavallo partirono per il fronte, lasciando questo angolo incantevole d’Inghilterra alla volta dell’inferno.
La guerra in cui i due si trovarono in Francia non assomigliava più a quella di cui Seely aveva letto e immaginato: trincee allagate, fango che inghiottiva uomini e cavalli, bombardamenti incessanti e una modernità bellica che rese fin da subito la cavalleria quasi obsoleta. La Prima Guerra Mondiale si mostrava adesso con il suo volto peggiore a Seely e Warrior. Da guerra lampo a guerra di logoramento. Dall’immobilità più totale alla furia della battaglia e panico della morte che si scatenavano in attimi, improvvisamente.
Warrior, tuttavia, mostrò fin da subito una calma fuori dal comune, una reattività che non degenerava mai nel panico. Seely ricordò più tardi che “Warrior was the horse the enemy could not kill”, non come celebrazione esagerata, ma come constatazione maturata giorno dopo giorno sul campo. Warrior salvò letteralmente la vita al suo padrone, più e più volte. Perché, per quanto ormai obsoleto, avere un cavallo come compagno fidato al proprio fianco fa sempre la differenza, soprattutto in guerra.
Seely ha raccontato numerosi aneddoti, per esempio a Ypres, nel 1915, il cavallo sfuggì a un bombardamento incendiario che stava avvolgendo l’unità britannica durante una manovra di ripiegamento: mantenne la direzione nonostante le fiamme e la confusione, portandolo fuori dal settore colpito. Episodi simili si ripeterono a più riprese, con schegge che sfioravano Warrior e proiettili che colpivano il terreno a poche lunghezze da loro.
Poi arrivò un momento memorabile, una delle ultime grandi cariche di cavalleria della Storia: marzo 1918, Battaglia di Moreuil Wood. Lì, in un bosco devastato, tra trochi spezzati e il terreno pieno di buche e cenere, Seely guidò l’assalto, tra i canadesi impegnati a respingere l’avanzata tedesca. Warrior affrontò in testa il fuoco diretto delle mitragliatrici mantenendo un controllo impeccabile, mentre tanti altri cavalli, intorno a lui, venivano uccisi. Warrior rimase illeso. Un miracolo? Voglia di vivere? Non si saprà mai, tanto sta che Warrior riportò ancora a casa il suo padrone.
In una guerra in cui vennero utilizzati oltre dieci milioni di cavalli e di cui veramente pochissimi tornarono a casa, la storia di Warrior ha dello straordinario. Ma non fu solo una questione di fortuna isolata. Warrior possedeva una combinazione rara di resistenza fisica, buon carattere, molto equilibrato, capacità di adattarsi a condizioni estreme e un legame incredibile con il suo cavaliere, con cui, si può ben dire, erano veramente un binomio. Non esiste uno senza l’altro.
Quando la guerra finì, Seely tornò a casa, nella pace dell’isola di Wight e, ovviamente, portò con sé anche Warrior. Così come erano partiti, adesso erano finalmente tornati. Certo non erano più gli stessi. Non era lo stesso uomo e non era lo stesso cavallo, ma adesso erano un binomio più unito che mai, tanto che Seely decise di non destinare Warrior a ruoli celebrativi o a una carriera ufficiale nell’esercito: ma lo tenne con sé, come cavallo di famiglia fino al 1941, partecipando solo occasionalmente a cerimonie commemorative.
A quasi settant’anni di distanza, nel 2014, Warrior ha ricevuto, postuma, la Dickin Medal, il massimo riconoscimento britannico al valore animale. Non fu una decorazione romantica, ma il riconoscimento di un servizio continuativo sotto condizioni estreme. Warrior non fu un cavallo “miracolato”, ma un cavallo che, insieme al proprio cavaliere, ha svolto il proprio compito in una guerra che inghiottiva quasi tutto ciò che toccava. La sua storia rimane significativa non per un presunto eroismo sovrannaturale, ma per ciò che rivela della resistenza dei cavalli e del legame profondo tra uomo e cavallo, un legame che, come ben sappiamo ancora oggi, può veramente determinare la differenza tra la vita e la morte. Seely lo capì bene, e le sue parole, asciutte e prive di retorica, restano forse la sintesi più onesta di quell’esperienza condivisa: “Warrior was the horse the enemy could not kill.”
Credit Photo: https://www.portsmouth.anglican.org/